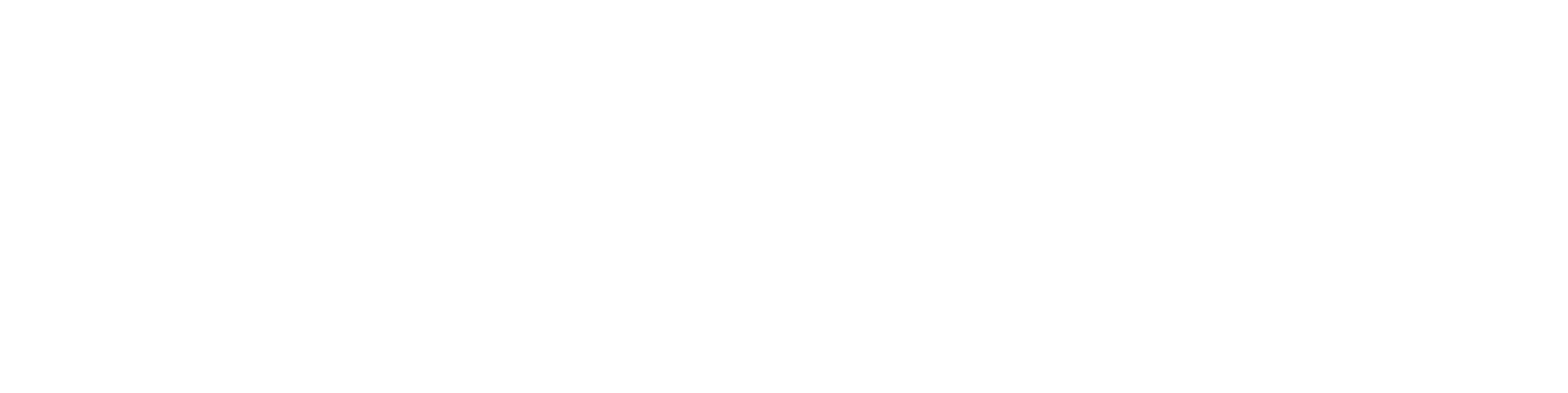Come costruire un ufficio inclusivo
La storia
In un workshop con i dipendenti di una grande azienda, mentre si parlava del momento in cui si erano sentiti sicuri di mostrare la propria unicità, una ragazza ha raccontato che era riuscita a esprimere per la prima volta il suo vero orientamento sessuale con il suo attuale team di lavoro. Fino a quel momento in azienda non aveva trovato un luogo sicuro per farlo. «È molto bello poter parlare apertamente con le persone con cui lavoro» ha commentato.
Cosa c’entra l’orientamento sessuale con il lavoro?
Credere che non sia necessario fare coming out al lavoro è il classico fraintendimento in cui cadono i lavoratori eterosessuali e cisgender che non affrontano lo stesso dilemma appartenendo alla maggioranza. Le persone LGBTIQ+ devono scegliere di fare coming out se vogliono essere visibili, se vogliono partecipare a occasioni di connessione come il racconto di un weekend, se vogliono stare dentro la loro verità in ogni momento della giornata. La possibilità o meno di fare coming out influisce moltissimo sulla felicità al lavoro e sui livelli di stress, come dimostrano numerose ricerche.
Il coming out influenza anche la carriera?
Inutile negarlo: ci sono contesti intrisi di pregiudizio, in cui ancora oggi potrebbe essere controproducente fare coming out. Ma in termini più generali, questo gesto dovrebbe facilitare la carriera. Perché noi ci fidiamo delle persone con cui creiamo connessione. Tale connessione si costruisce non su argomenti prettamente lavorativi ma su passioni, interessi. E se una persona è costretta a tenere nascosto un pezzo importante di sé non potrà mai partecipare alla corsa per costruire reti di influenze più o meno forti.
Cosa rende un ambiente di lavoro predisposto al coming out?
Il fatto di essere popolato da persone che si sono conquistate il diritto di ascoltare una certa storia. Facile a dirsi, più difficile a realizzarsi. Un’azione così semplice e istintiva come l’ascolto è una delle più difficili oggi da compiere. A complicarla, spiega Brené Brown, contribuisce il fatto che ci sono stati mentali molto simili a quelli dell’ascolto ma che in realtà lo minano. Lei li chiama nemici vicini. I principali sono: l’interruzione narrativa e l’acquisizione del controllo narrativo.
Quel vizio di interrompere…
«Le interruzioni impulsive sono una grande minaccia per l’ascolto. A meno che tu non riesca a controllare le tue emozioni, positive o negative che siano, entrerai in gioco troppo presto, senza lasciare che le persone esprimano il loro punto», spiega il dottor Tomas Chamorro-Premuzic su Fast Company.
…e di mettere noi stessi al centro di ogni storia
«L'acquisizione del controllo narrativo è un grosso problema nel nostro mondo», spiega Brené Brown. «Invece di essere buoni amministratori di una storia, dirottiamo la storia e ci mettiamo al centro, spostando l'attenzione su di noi, mettendo in discussione o non credendo a ciò che qualcuno sta condividendo perché è diverso dalla nostra esperienza vissuta, o sminuendo l’importanza di un’esperienza perché ci fa sentire a disagio o, peggio, complici. Quando rifiutiamo la verità della storia di qualcuno è perché ci siamo di nascosto messi al centro della sua storia. E lo abbiamo fatto per proteggere il nostro ego, comportamento o privilegio».
Come si ascolta veramente?
Brené Brown è chiarissima: «Come l’empatia, la gestione della storia non è camminare nei panni di qualcun altro, ma essere curiosi e creare fiducia narrativa mentre ti raccontano l’esperienza di essere nei loro panni. Si tratta di credere alle persone quando ti dicono cosa ha significato un’esperienza per loro».
L’ascolto attivo non consiste nel rimanere in silenzio mentre l’altra persona sta parlando o nel ripetere parola per parola ciò che hai sentito. «Secondo una ricerca di Zenger e Folkman», scrive Lalatendu Satpathy, «invece di pensare a un buon ascoltatore come a una spugna, che assorbe tutto ma fornisce pochi feedback, l’ascoltatore attivo dovrebbe comprendere il contesto, provare una profonda empatia per l’oratore e quindi porre domande per chiarire meglio e impegnarsi nella conversazione. L’ascoltatore attivo è come un trampolino che amplifica e supporta i pensieri di un oratore».
Il coming out non serve solo a chi lo fa
Lo sforzo per creare ambienti inclusivi va a vantaggio di tutti. Francesca Cavallo, co-autrice delle Favole della buonanotte per bambine ribelli, nella sua autobiografia appena uscita, Ho un fuoco nel cassetto (Salani, 2022), racconta che il coming out non si fa una volta sola. Chi è lesbica, gay, transgender, queer fa coming out tutta la vita, ogni volta che affitta casa, cambia lavoro, fa una passeggiata col partner. Ma il coming out è un’occasione di crescita anche per tutti quelli che sono attorno. «Si tratta di trovare il nostro modo di mantenere un dialogo aperto e di stare il più possibile dentro la nostra verità».
Quando gli chiedevano conto del suo silenzio durante le riunioni, Rockefeller rispondeva spesso con una poesia: «Un vecchio gufo saggio viveva su una quercia. Più cose vedeva e meno parlava. Meno parlava e più ascoltava. Perché non siamo tutti come lui?»
Questo articolo è tratto dal numero 25 del 4 giugno 2022 della newsletter “Voices”, una newsletter settimanale di Diagonal curata da Annalisa Monfreda. Ogni settimana racconta storie, voci, dati e approfondimenti per ispirarti lungo il percorso verso un’azienda inclusiva. Siamo infatti convinte che la diversità sia la più grande opportunità di innovazione che abbiamo, l’occasione di riscrivere le regole del lavoro, di ridisegnarne i riti, gli spazi, la cultura. Se desideri iscriverti clicca qui. Ti aspettiamo!